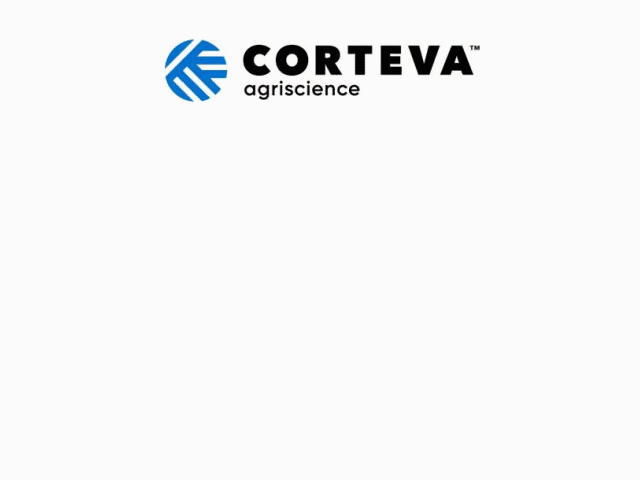Pasquale De Vita, Dirigente del CREA-CI di Foggia, racconta a Grano Italiano il progetto del Piano Nazionale delle Sementi Biologiche (PSNB) e le attività previste per il frumento duro e tenero. Capiamone di più.
Dott. Pasquale De Vita, partiamo dalle basi: cos’è il Piano Nazionale delle Sementi Biologiche e quale necessità lo ha reso necessario?
Il Piano Nazionale delle Sementi Biologiche 2025-2027 nasce dalla volontà del MASAF di dare piena attuazione agli obiettivi previsti dalla legge 23/2022 per lo sviluppo dell’agricoltura biologica. Il suo scopo principale è ridurre in modo strutturale il ricorso alle deroghe, ovvero l’uso di sementi convenzionali nei sistemi di produzione biologici, che oggi rappresenta ancora un problema significativo. Questo accade perché il settore sementiero non riesce ancora a offrire, in quantità e qualità adeguate, varietà realmente adatte alle esigenze dell’agricoltura biologica. Il PNSB, quindi, si pone come strumento di sistema per aumentare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e per incentivare lo sviluppo di varietà e popolazioni eterogenee adatte a coltivazioni prive di input chimici, in contesti ambientali e pedoclimatici estremamente diversificati come quelli italiani.
Quali sono gli attori coinvolti nell’attuazione di questo Piano e quali i principali ambiti di lavoro?
Il coordinamento nazionale è affidato al CREA-DC, ma sono coinvolti in modo operativo diversi centri del CREA, tra cui il nostro centro CREA-CI, che ha la responsabilità scientifica delle attività riguardanti le specie agrarie – in particolare frumento duro, frumento tenero e riso – nell’ambito della macroarea 3 “Innovazione”. Altri centri CREA come il CREA-OF, il CREA-PB, CREA-OFA e CREA-VE curano le attività relative ad altre filiere (orticole, politiche di filiera, fruttifere). L’approccio è multidisciplinare, integrato e soprattutto partecipativo, con un forte coinvolgimento di agricoltori, tecnici, ditte sementiere e stakeholder locali.
In quale contesto si inserisce questo Piano? E perché proprio adesso è così urgente agire?
De Vita: Il Piano si inserisce in un contesto europeo ed italiano in grande evoluzione. Le strategie del Green Deal e della Farm to Fork spingono verso una transizione ecologica dell’agricoltura, con obiettivi chiari di riduzione dell’uso di prodotti chimici e di aumento della superficie coltivata con metodo biologico. Tuttavia, questo processo rischia di rimanere incompiuto se non si risolvono i colli di bottiglia che ostacolano la piena autonomia della produzione biologica, a partire proprio dalla disponibilità di sementi adatte. È inaccettabile, a distanza di anni dall’introduzione del biologico nel sistema normativo europeo, che ancora oggi molte aziende agricole siano costrette a utilizzare sementi convenzionali per mancanza di alternative. Occorre quindi rafforzare il comparto sementiero biologico, sia sul piano quantitativo che qualitativo, incentivando la costituzione di nuove varietà e popolazioni in grado di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, alla pressione delle malattie e alla sostenibilità economica delle aziende agricole.
Entrando più nel dettaglio, quali sono le attività previste dal CREA-CI per le specie agrarie frumento duro, tenero e riso?
Le nostre attività si articolano in quattro linee di intervento principali. La prima riguarda la creazione di una rete di collaborazione con agricoltori e stakeholder, attraverso incontri, workshop e momenti formativi, con l’obiettivo di garantire un approccio partecipativo al miglioramento genetico. Coinvolgere i portatori di interesse significa orientare fin dall’inizio le attività di selezione verso bisogni reali, aumentando le probabilità di successo e di adozione delle varietà sviluppate.
La seconda linea riguarda lo sviluppo di Materiale Eterogeneo Biologico (MEB), sia dinamico (come le popolazioni evolutive) sia statico (come i miscugli), attraverso l’utilizzo di materiale genetico vario – varietà tradizionali, linee in selezione, varietà da conservazione – e la loro moltiplicazione in campo biologico. I miscugli vengono selezionati anche in funzione delle loro caratteristiche qualitative, come l’attitudione alla pastificazione e/o alla panificazione, e testati direttamente sul campo con il supporto degli agricoltori.
La terza attività è centrata sul miglioramento genetico per linea pura, finalizzato a ottenere nuove varietà con caratteristiche specifiche: resistenza alle malattie trasmesse da seme, tolleranza alle infestanti e maggiore efficienza d’uso dell’azoto. Tutti aspetti cruciali in agricoltura biologica, dove l’uso di prodotti chimici e fertilizzanti è fortemente limitato. Usiamo anche tecnologie avanzate di fenotipizzazione e selezione assistita, sempre nel rispetto delle regole del biologico.
Infine, con la Rete Nazionale di Prove di Confronto Varietale testiamo le varietà più promettenti – comprese quelle da conservazione e i MEB – in più località italiane, con l’obiettivo di verificarne adattabilità, performance agronomica, qualità tecnologica e resistenza alle principali patologie. Queste prove sono fondamentali per dare evidenza scientifica alle potenzialità dei materiali genetici e supportare eventuali processi di registrazione varietale.
Quali sono i risultati attesi e come pensate che queste attività possano cambiare il settore?
Ci aspettiamo un impatto su più livelli. Dal punto di vista tecnico, vogliamo offrire al comparto biologico materiali genetici migliori e più adatti, in grado di rispondere alla domanda crescente di sementi certificate. A livello strategico, puntiamo a rafforzare la filiera sementiera biologica italiana, che oggi è ancora troppo debole per sostenere una domanda in forte espansione. E infine, sul piano normativo, il nostro contributo servirà anche a migliorare le valutazioni per l’iscrizione al Registro Nazionale di nuove varietà e per la riduzione delle deroghe, attraverso dati sperimentali affidabili. Se riusciremo a rendere disponibili sementi biologiche di qualità, adatte e tracciabili, sarà possibile diminuire sensibilmente l’utilizzo delle deroghe, con benefici per tutto il sistema.
Vorrei chiudere con una domanda che tocca un tema sensibile. Oggi le Tecnologie di Evoluzione Assistita (TEA) note anche come genome editing, sono escluse dal comparto biologico. Come vede questa limitazione?
Nel progetto del PNSB, non è previsto l’uso di genome editing né di TEA. Tutte le attività di miglioramento genetico saranno sviluppate nel rispetto delle regole vigenti per il biologico. Utilizzeremo metodologie avanzate ma accettate, come la selezione assistita da marcatori molecolari (MAS) per tratti fenotipici semplici (i.e. resistenza a patogeni trasmessi da seme), e tecniche di Genomic Selection per affrontare caratteri complessi, come l’efficienza nell’uso dell’azoto o la tolleranza alle infestanti. Questi strumenti ci permettono di accelerare la selezione varietale, senza violare i principi normativi attuali.
Detto ciò, personalmente ritengo che la ricerca non possa permettersi barriere ideologiche, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove l’agricoltura è esposta a sfide sempre più complesse, dai cambiamenti climatici alla pressione fitosanitaria. Limitare per principio l’uso delle TEA, incluso il genome editing, significa privarci di potenzialità straordinarie per migliorare sostenibilità, resilienza e competitività delle colture. Va riconosciuto infatti che le TEA sono tecnologie rivoluzionarie che permettono di modificare il DNA delle piante con elevata precisione, agendo come delle “forbici molecolari” per tagliare, modificare o sostituire specifiche sequenze genetiche, e rappresentano un’evoluzione scientifica rispetto alle tecniche OGM del passato basate sull’introduzione casuale di geni estranei.
———————-
Di seguito, le tabelle che mostrano i risultati produttivi di 19 varietà testate in 7 campi di prova nella stagione 24-25, nell’ambito di prove di frumento duro in coltura biologica eseguite dal CREA (tabella 1, 2 e tabella B e A).




Puoi seguirci anche sui social, siamo su Facebook, Linkedin e Instagram